Il mondo degli scrittori in Italia è da sempre diviso in due sulla domanda: si può insegnare a scrivere? Esiste una tecnica che può essere trasmessa da una parte e imparata dall’altra? A dir la verità, fino a poco tempo fa la risposta era unanime: un grande, sonoro NO. La comunità degli scrittori (italiani) non aveva dubbi.
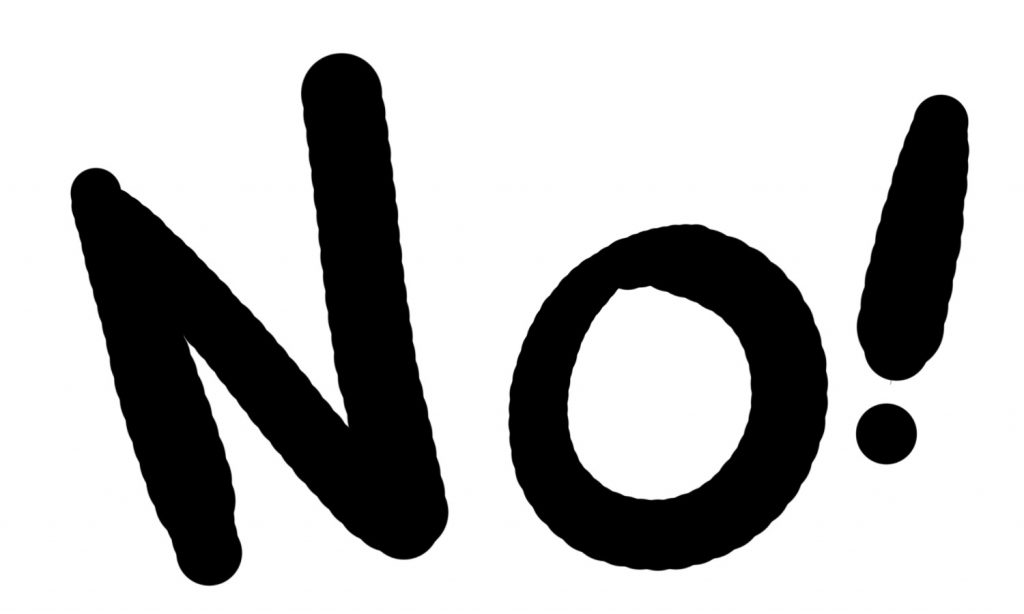
Ma poi le cose sono cominciate a cambiare e qualcuno, come me, l’ha vissuto in diretta. Dopo aver studiato su manuali di scrittura inglesi, convinta che imparare la tecnica, come in qualsiasi arte, fosse importante, sono stata proprio io a pubblicare il primo manuale di scrittura italiano per aspiranti scrittori per ragazzi, nel 2011. Fu solo l’inizio di un periodo che, in tal senso, diede il via a grandi cambiamenti.
È innegabile che il trend sia partito dal mondo anglosassone. Dopo il fenomeno Harry Potter, nessuno è stato più in grado di resistere all’urto del mercato globale. Sono cominciate a spuntare scuole di scrittura, corsi, masterclass e ogni tipo di formazione (a parte quella universitaria…) per chi da grande vuole fare lo scrittore. Molti editori di manualistica hanno tradotto i manuali americani e inglesi più famosi (Story di McKee, un capolavoro) e l’Italia si è messa in carreggiata rispetto all’insegnamento della scrittura creativa. Gli autori si sono divisi in due fazioni: i pro-talento e i pro-tecnica.
Resta il dubbio che sia un falso dilemma. Un individuo senza talento con la tecnica ci farà ben poco; la tecnica non è un lasciapassare e per capirla bisogna avere… talento. Almeno un po’. Al contrario, un autore capace che ha contato solo su se stesso e sulla propria ispirazione, con la tecnica può esplorare nuove possibilità e sperimentare approcci diversi. Le due cose, in pratica, vanno insieme. O sarebbe meglio che fosse così.
Io sono una fan della tecnica – non a caso organizzo ogni anno un corso di scrittura patrocinato dall’ICWA – e sicuramente pesano su questa mia impostazione i sei anni nell’università inglese, in cui studiare scrittura creativa è un’opzione come un’altra, così come “fare lo scrittore” è una carriera a tutti gli effetti, di cui si possono imparare le regole (saperle applicare, poi, è un altro discorso, come per ogni disciplina).
Ma il fatto è che studiare qualcosa che si ama è APPASSIONANTE. Conoscerne nuovi aspetti, guardare nuove angolazioni è semplicemente gratificante, stimolante, sorprendente. È davvero un modo per acquisire nuovi strumenti o per usare con consapevolezza quelli che già si posseggono grazie alla pratica. È avere la possibilità di abbracciare fino in fondo qualcosa che si ama.
Quando la tecnica non c’è, poi, si vede.
Romanzi con ottime premesse cadono su questioni che sarebbero state facilmente risolvibili con un po’ di studio, e il risultato spesso sono:
- calo della tensione o della sospensione dell’incredulità;
- finali fiacchi
- temi e argomenti risolti a metà e
- un mare di stereotipi.
A volte mi chiedo: e se fosse questo il motivo per cui traduciamo così poco all’estero? In fondo gli editori stranieri conoscono la tecnica e riconoscono le strutture narrative che ne sono prive. Se fosse anche per questo che non abbiamo mordente fuori dai confini nazionali, perché giochiamo secondo regole che non sono condivise da nessuno?
La domanda resta aperta.
Le due fazioni continuano a dibattere. “Non dobbiamo imitare gli inglesi” dice qualcuno – ma sempre dall’interno del mercato globale, ormai ampiamente dominato dalla lingua inglese e da regole che non vengono certo decise dalle culture subalterne.
Io resto dell’idea che studiare è sempre bene e che decidere di non utilizzare ciò che si è imparato è una possibilità migliore dell’inconsapevolezza. Studiare qualcosa che si ama, poi, è una gran fortuna e un privilegio. Forse bisognerebbe partire da qui.


